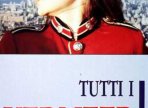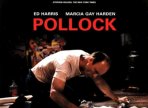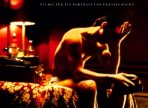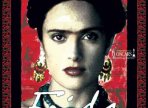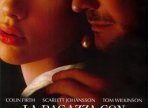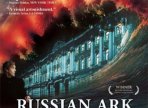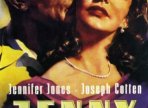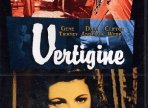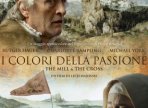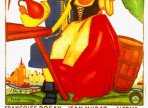Nel novembre 1992 il Circuito Cinema
propose una rassegna, che vantò un ottimo
riscontro di pubblico, sul rapporto fra la settima
arte e la pittura e, per l’occasione, uscì
il Quaderno Cinema & Pittura. Ora, ventitré
anni dopo, un’altra rassegna, fra settembre
e ottobre, farà il punto della situazione su
quest’argomento sempre estremamente stimolante,
tornato più che mai alle cronache
anche per il successo dell’ottimo Turner di
Mike Leigh.
Tredici film metteranno a fuoco alcune fra
le tante relazioni che intercorrono fra queste
due forme d’arte: biopic, più o meno trasgressivi
(Love is the Devil, Pollock e Frida),
opere che affrontano la complessa relazione
che si viene a creare fra la figura del pittore
e la raffigurazione della realtà (I misteri del
giardino di Compton House, il film di esordio
di Greenaway, e La ragazza con l’orecchino di
perla), film con citazioni pittoriche (La kermesse
eroica, forse il capolavoro in assoluto
del genere), quelli che propongono un registro
di stile prettamente pittorico (il bizzarro
Al di là dei sogni e il mirabolante L’arca
russa), quelli in cui un quadro è il cardine
attorno a cui gira il plot (Vertigine, Il ritratto
di Jennie), quelli che si interrogano sulla contrapposizione
fra l’arte e la società materialista
(Tutti i Vermeer di New York, un piccolo
gioiello del cinema indipendente americano),
fino a quelli che entrano nei gangli, addirittura
fin dentro il tessuto pigmentato del
dipinto, ludicamente (Il maestro fi ammingo)
o più acutamente (I colori della passione, nel
quale il polacco Lech Majewski compie un’operazione
curiosa quanto riuscita a proposito
della Salita al Calvario di Pieter Bruegel il
Vecchio).
Tutti casi molto interessanti, dunque, che
però pure non completano l’articolata e sfaccettata
casistica, dalle impalpabili nuances,
che lega le due arti. Queste di fondo condividono
evidentemente, assieme alla fotografi
a, l’immagine di base. Naturalmente è stato
soprattutto il cinema a rifarsi alla pittura (ma
il caso inverso, dei pittori che si ispirano al
cinema, è tutt’altro che trascurabile). Così è
stato sin dagli albori del cinema, quando la
nuova arte si imbevve spesso e volentieri di
citazioni pittoriche, regalandosi così un tono
di nobile artisticità che voleva riscattare l’evidente
senso d’inferiorità e che, nello stesso
tempo, intendeva convincere i tanti detrattori
che sostenevano che il cinema non fosse
un’espressione artistica. In seguito però il
discorso si è irrobustito, allargandosi dai casi
più ovvi – quelli che si limitano al mero piano
fi gurativo, come la citazione di un dipinto
(plan-tableau) o un tableau vivant – ad altri
aspetti più squisitamente formali, e quindi
più ricercati e sottili, che interessano dunque
la luce, il colore, il taglio dell’inquadratura, i
valori lineari, plastici ecc.
Detto ciò, alla lunga, due si sono rivelati gli
spunti della pittura che più hanno attratto
il cinema. Il primo è stato il fatto che la pittura
è in grado di offrire a scenografi , direttori
della fotografia e registi uno sterminato
campionario di soluzioni formali di grande
efficacia e inventiva. Si pensi, in particolare,
a Caravaggio, Vermeer o Hopper, forse i pittori
dalla più evidente cinematograficità, che
più di tutti hanno funto da ispirazione (ma si
ricordi che, a sua volta, il pittore americano
ha preso molto dal cinema). Il secondo è il
confronto, quanto mai intrigante e ricco di
sorprese, tra i due differenti mezzi espressivi
– tela vs schermo, occhio del pittore vs obiettivo
fotografico – che ha attratto soprattutto
i registi più inclini a discorsi metafilmici,
come Godard, Pasolini o Greenaway. I risultati
sono stati, com’è ovvio che sia, quanto
mai variegati. Se infatti talora la citazione
pittorica appare fondamentalmente inutile,
quasi uno sterile scimmiottamento, viceversa
ci sono film eccezionali, nei quali le fonti
pittoriche non solo hanno permeato il film
di rara poesia ma alla fine ne sono uscite esse
stesse arricchite, in una felice contaminazione
di linguaggi, diversi eppure per molti versi
affini.